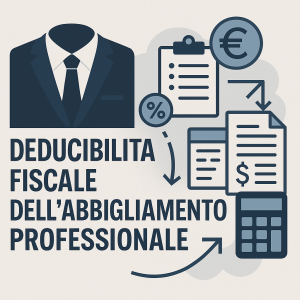
A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola
La questione della deducibilità delle spese per l’abbigliamento nel contesto del reddito d’impresa e di lavoro autonomo si configura come una delle tematiche più controverse nell’ambito dell’interpretazione dell’articolo 109, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), laddove si rinvia implicitamente al principio dell’inerenza. Tale principio, pur non trovando una codificazione esplicita nella norma, è stato oggetto di elaborazione giurisprudenziale progressiva, assumendo nel tempo una dimensione di tipo qualitativo, fondata sull’utilità e funzionalità del costo rispetto all’attività economica esercitata, anche in prospettiva futura.
La Corte di cassazione, con costanza ermeneutica, ha definito l’inerenza come il nesso eziologico tra il costo sostenuto e l’attività imprenditoriale o professionale, inteso non necessariamente in termini diretti e immediati con i ricavi, ma in senso più ampio e strutturale. Tale orientamento, ribadito nelle più recenti decisioni nn. 9568, 9132, 8922 e 8700 del 2025, si traduce in un’interpretazione restrittiva per le spese aventi natura potenzialmente promiscua, come quelle relative all’acquisto di abiti civili o di rappresentanza. Tali spese, sebbene utilizzate esclusivamente in ambito lavorativo, vengono di regola escluse dalla deduzione in quanto prive del carattere di esclusività funzionale all’attività esercitata.
La giurisprudenza distingue pertanto in modo netto tra abbigliamento generico, che può essere indifferentemente adoperato in contesti lavorativi e privati, e abbigliamento tecnico o funzionale, la cui natura specifica e obbligatorietà normativa (si pensi ai dispositivi di protezione individuale o alle divise sanitarie) legittima senz’altro la deducibilità del relativo costo. In tale contesto, l’onere della prova circa la sussistenza dell’inerenza grava sul contribuente, in applicazione del principio di vicinanza della prova, il quale, in deroga alla regola generale dell’art. 2697 cod. civ., pone a carico della parte più prossima alla fonte probatoria la dimostrazione dell’assunto dedotto, specie in presenza di elementi di dubbio sull’effettiva destinazione della spesa.
Occorre evidenziare che, sebbene l’Amministrazione finanziaria debba motivare le riprese fiscali in sede di accertamento, l’onere documentale a carico del contribuente impone la predisposizione di un impianto probatorio idoneo a dimostrare, caso per caso, il vincolo funzionale tra il bene acquisito e l’attività svolta. In tale ottica, appare imprescindibile una valutazione sostanziale e concreta delle circostanze fattuali, onde evitare applicazioni automatiche e generalizzate dei criteri di inerenza.
Nonostante l’approccio restrittivo della giurisprudenza di legittimità, alcune pronunce di merito hanno aperto margini interpretativi più flessibili, riconoscendo, in taluni casi, una deducibilità parziale delle spese per abbigliamento laddove sussistano vincoli contrattuali specifici o esigenze di scena che impongano l’adozione di un determinato outfit. È il caso, ad esempio, di artisti, personaggi dello spettacolo o operatori del settore della moda e della comunicazione, la cui immagine pubblica costituisce parte integrante della prestazione professionale resa. In tali ipotesi, la giurisprudenza ha talvolta ritenuto applicabile una deducibilità forfettaria, sovente fissata nella misura del 50%, in assenza di criteri oggettivi di ripartizione dell’utilizzo promiscuo.
Un’ulteriore evoluzione interpretativa si rinviene nella recente sentenza n. 959/2/24 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino, che ha accolto l’istanza di un commercialista affermato, riconoscendo la deducibilità dei costi sostenuti per l’acquisto di capi d’abbigliamento di pregio, in ragione delle funzioni pubbliche ricoperte e della conseguente esigenza di mantenere un elevato standard di decoro professionale. In tale pronuncia, il giudice ha valorizzato l’immagine pubblica del contribuente quale elemento costitutivo della sua attività e ha ritenuto che l’abbigliamento formale potesse essere qualificato come spesa funzionalmente inerente alla prestazione resa, in quanto strumentale alla tutela della reputazione e credibilità professionale.
Alla luce delle considerazioni esposte, si impone una riflessione critica sull’attuale quadro interpretativo, caratterizzato da una tensione costante tra esigenze di rigore fiscale e tutela della peculiarità delle singole attività economiche. L’approccio giurisprudenziale più recente suggerisce la necessità di adottare un criterio di valutazione elastico, fondato su parametri oggettivi e coerenti con la realtà economica sottostante, in grado di garantire un equo bilanciamento tra le esigenze dell’erario e i diritti del contribuente. La costruzione di un sistema di deducibilità improntato su criteri di effettiva strumentalità e non su mere presunzioni formali rappresenta una prospettiva evolutiva coerente con i principi di proporzionalità e ragionevolezza che dovrebbero improntare ogni intervento ermeneutico in materia tributaria.
27 agosto 2025
