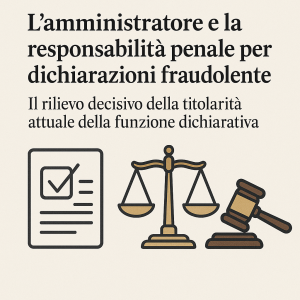
A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola
L’ordinanza n. 25455 del 2025, recentemente pronunciata dalla Corte di Cassazione, offre una significativa occasione di riflessione sul perimetro soggettivo e temporale della responsabilità penale in materia di dichiarazioni fraudolente fondate sull’utilizzo di documentazione fiscalmente artefatta, in particolare le c.d. false fatture. L’intervento del Supremo Collegio si colloca nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale, riaffermando principi cardine del diritto penale tributario, e apporta ulteriori chiarimenti di ordine sistematico sulla corretta identificazione del soggetto attivo del reato in questione.
La questione centrale affrontata attiene alla qualificazione soggettiva dell’autore del delitto previsto dall’art. 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nella specifica ipotesi in cui vi sia un avvicendamento nella compagine amministrativa della società contribuente. In particolare, viene esclusa qualsiasi forma di responsabilità penale in capo al soggetto che abbia cessato dalle funzioni di amministratore anteriormente al deposito della dichiarazione fiscale fraudolenta, anche qualora questi abbia partecipato, in epoca antecedente, alla gestione documentale e contabile prodromica all’illecito dichiarativo. Di converso, si afferma la piena responsabilità in capo all’amministratore in carica al momento della sottoscrizione della dichiarazione mendace, individuato quale unico soggetto legittimamente destinatario dell’obbligo giuridico di dichiarazione.
La ricostruzione dogmatica accolta dalla Corte si fonda sull’individuazione del reato di cui all’art. 2 del D.lgs. n. 74/2000 come reato proprio, la cui realizzazione presuppone che l’agente rivesta una particolare qualifica soggettiva, non meramente formale, ma sostanziale, consistente nell’effettiva titolarità dell’obbligo dichiarativo. In tale prospettiva, si ribadisce che non rileva la semplice predisposizione o registrazione contabile delle fatture oggettivamente inesistenti, bensì esclusivamente la presentazione della dichiarazione fiscale contenente tali elementi fittizi. La consumazione del reato si verifica, infatti, con la trasmissione della dichiarazione infedele, la quale rappresenta il momento topico di esternazione della volontà fraudolenta e consente l’integrazione dell’elemento oggettivo del reato.
Ne consegue che l’imputabilità penale non può che gravare sul soggetto che, al momento del deposito della dichiarazione, risulta formalmente investito della funzione amministrativa, ovvero la esercita de facto in modo continuativo, sistematico e non meramente occasionale. La Corte esclude, altresì, ogni rilevanza penale per la posizione di chi, pur avendo esercitato precedentemente un ruolo gestionale, abbia cessato dalla funzione senza essere intervenuto nella fase di presentazione della dichiarazione fraudolenta.
La pronuncia in esame valorizza, con particolare rigore, la distinzione tra le condotte preparatorie interne all’organizzazione aziendale, che restano irrilevanti ove non sfocino nell’atto dichiarativo, e l’effettivo compimento dell’illecito penalmente rilevante, individuato nella dichiarazione mendace resa all’Amministrazione finanziaria. In tal senso, si rafforza l’idea secondo cui l’elemento temporale della titolarità della carica costituisce requisito strutturale della responsabilità penale, e non mera connotazione accidentale.
Questa impostazione si colloca in piena coerenza con i principi di legalità e personalità della responsabilità penale sanciti, rispettivamente, dagli artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, nonché con il principio di offensività, in quanto l’effettivo disvalore giuridico del fatto si manifesta solo con la presentazione della dichiarazione falsa, e non con le fasi preparatorie che, in assenza di tale atto, resterebbero penalmente inerti.
La Corte, peraltro, compie una rilettura evolutiva della disciplina già delineata dalla giurisprudenza antecedente, a partire dalla sentenza n. 516 del 1989, ampliando e precisando l’ambito di applicazione dell’art. 2 in relazione al momento consumativo e al profilo soggettivo dell’agente. Tale prospettiva interpretativa si mostra idonea a evitare indebite sovrapposizioni tra responsabilità penale e responsabilità gestionale interna, circoscrivendo l’ambito dell’imputazione penale ai soli casi in cui sussista un effettivo collegamento tra il soggetto attivo e l’adempimento dichiarativo fraudolento.
La responsabilità penale per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti si radica esclusivamente nella figura dell’amministratore in carica — formale o di fatto — al momento della sottoscrizione della dichiarazione, nella sua qualità di titolare del relativo obbligo legale. Ogni altra condotta, anche se idonea a integrare una forma di concorso materiale nella predisposizione dei mezzi fraudolenti, resta penalmente irrilevante qualora non si traduca in una partecipazione diretta all’atto dichiarativo.
8 settembre 2025
