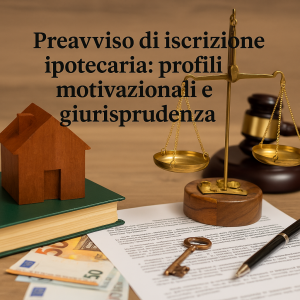
A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola
L’ordinanza n. 25456/2025 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, si inserisce in un filone giurisprudenziale di grande rilievo per le implicazioni applicative che essa comporta in materia di riscossione coattiva mediante iscrizione ipotecaria. La pronuncia affronta, in particolare, la questione relativa all’onere motivazionale gravante sull’agente della riscossione nella fase del preavviso di iscrizione ipotecaria, ai sensi dell’art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, norma che si colloca nel sistema di tutela procedimentale del contribuente nel quadro dell’esecuzione forzata tributaria.
Nel contesto del giudizio tributario da cui trae origine la pronuncia in commento, il contribuente impugnava il preavviso di iscrizione ipotecaria contestando, tra l’altro, la mancata indicazione dei beni immobili sui quali si sarebbe proceduto all’iscrizione del vincolo, ritenendo che tale omissione costituisse un vizio di motivazione dell’atto preordinato alla costituzione della garanzia reale. La Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente il ricorso, ritenendo l’atto carente sul piano motivazionale. La Corte di Cassazione, tuttavia, nel riformare tale statuizione, ha precisato con chiarezza che il preavviso di iscrizione ipotecaria previsto dalla norma citata ha natura meramente informativa e sollecitatoria, con funzione non sostanzialmente provvedimentale, e che non è richiesto che esso rechi specificamente l’indicazione dei beni immobili che potrebbero essere oggetto dell’iscrizione ipotecaria.
Secondo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, la comunicazione preventiva deve contenere unicamente l’indicazione del credito oggetto di riscossione, con riferimento sia all’an (cioè al titolo giustificativo) sia al quantum (cioè all’entità della pretesa), mentre resta estranea alla struttura tipica dell’atto qualsiasi specificazione dei beni su cui l’agente della riscossione intende esercitare il diritto di garanzia. Solo al momento dell’effettiva iscrizione dell’ipoteca, da perfezionarsi mediante annotazione presso i registri immobiliari, si rende necessaria l’individuazione puntuale degli immobili, quale presupposto indefettibile per l’opponibilità del vincolo ai terzi e per la validità della garanzia reale.
Questa interpretazione trova fondamento, oltre che nel dato testuale della disposizione, anche in una lettura sistematica della disciplina in tema di responsabilità patrimoniale generale del debitore, delineata all’art. 2740 del codice civile. In virtù di tale principio, il creditore può scegliere discrezionalmente quali beni del debitore aggredire in sede esecutiva, senza che sia imposto un obbligo preventivo di specificazione. Pertanto, l’omessa indicazione degli immobili nel preavviso non incide in alcun modo sul diritto di difesa del contribuente, il quale, in quanto proprietario, è pienamente consapevole della consistenza del proprio patrimonio e può reagire, se del caso, contro un’eventuale iscrizione ipotecaria illegittima, mediante i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento.
La pronuncia in esame ha altresì chiarito che l’eventuale sproporzione tra l’importo del credito vantato e l’entità dell’iscrizione ipotecaria non comporta l’invalidità dell’atto, bensì impone al giudice tributario, qualora adito, di disporne la riduzione ai sensi dell’art. 2872 del codice civile. Ciò in conformità al disposto dell’art. 77, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, che stabilisce che l’ipoteca possa essere iscritta per un valore pari al doppio del credito da garantire. In tale prospettiva, la sproporzione non determina la caducazione integrale del vincolo, ma ne impone la riconduzione entro i limiti legali, rafforzando la finalità di garanzia dell’istituto senza comprometterne la funzionalità esecutiva.
Particolarmente significativo, poi, appare il richiamo al principio del raggiungimento dello scopo, ex art. 156 del codice di procedura civile, in materia di notificazione degli atti presupposti. La Suprema Corte ribadisce infatti che l’eventuale nullità della notificazione di una cartella di pagamento si considera sanata laddove il contribuente abbia comunque esercitato il proprio diritto di impugnazione, ottenendo in tal modo la piena conoscenza dell’atto. In tale ipotesi, si verifica l’effetto sanante ex tunc della notificazione, che ne impedisce l’invalidazione successiva in sede contenziosa, garantendo il bilanciamento tra esigenze di effettività dell’azione amministrativa e tutela del diritto di difesa.
Infine, sotto il profilo sostanziale, la Corte affronta la questione della prescrizione delle pretese tributarie, affermando che, per i crediti erariali afferenti a imposte quali IRPEF, IRES, IRAP e IVA, si applica il termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall’art. 2946 del codice civile. Tale affermazione si fonda sull’assenza di una norma che preveda, per tali tributi, un termine prescrizionale più breve e sull’impossibilità di ritenere detti crediti come obbligazioni periodiche ai sensi dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. La scadenza del termine per proporre opposizione agli atti della riscossione non comporta, pertanto, la cosiddetta conversione del termine breve in quello ordinario, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ., se non quando intervenga un titolo giudiziale passato in giudicato. Si tratta di un principio di grande rilievo sistematico, che chiarisce una questione spesso oggetto di contenzioso e di prassi difformi presso i giudici tributari di merito.
L’ordinanza n. 25456/2025 rappresenta un’importante presa di posizione della giurisprudenza di legittimità, la quale, nell’enunciare un principio di diritto di portata generale, contribuisce a definire con maggiore precisione i limiti formali e sostanziali del preavviso di iscrizione ipotecaria. La pronuncia rafforza la coerenza sistematica tra le norme speciali in materia di riscossione coattiva e i principi generali del diritto civile e processuale, offrendo agli operatori del diritto uno strumento interpretativo affidabile e autorevole, idoneo a orientare sia l’attività dell’amministrazione finanziaria sia la tutela giurisdizionale dei diritti dei contribuenti.
18 settembre 2025
