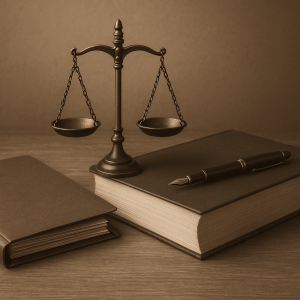
A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
L’evoluzione della responsabilità aggravata per lite temeraria nel processo tributario, oggetto di un articolato percorso interpretativo, trova un recente punto di snodo nella sentenza n. 142/2025 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa. Tale decisione si inserisce in un quadro normativo e giurisprudenziale arricchito dalle pronunce della Corte di cassazione nn. 4702/2025 e 13315/2025, le quali ne hanno precisato i presupposti applicativi, ribadendo l’essenzialità dell’elemento soggettivo di mala fede o colpa grave e la natura sanzionatoria della condanna prevista dall’art. 96 del codice di procedura civile. Il coordinamento tra queste fonti consente di delineare una ricostruzione organica dell’istituto nell’ambito del processo tributario, che appare oggi pienamente integrato nella dinamica del giusto processo e della tutela della buona fede processuale.
La sentenza della Corte di Pisa prende le mosse da un contenzioso avente ad oggetto un avviso di accertamento IRAP, successivamente annullato in autotutela dall’amministrazione finanziaria in quanto adottato senza contraddittorio preventivo. La parte contribuente, pur prendendo atto dell’annullamento, ha chiesto il risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., lamentando che l’omissione procedimentale avesse impedito la definizione agevolata prevista dalla legge n. 197/2022. Il Collegio, pur riconoscendo l’applicabilità dell’art. 96 c.p.c. al processo tributario per effetto del rinvio operato dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, ha escluso la sussistenza dei presupposti soggettivi dell’illecito processuale, ritenendo non provate né la mala fede né la colpa grave dell’Ufficio.
L’approfondita motivazione della Corte toscana, che richiama l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in materia, conferma che la responsabilità aggravata costituisce una figura autonoma, distinta tanto dalla responsabilità civile ordinaria ex art. 2043 c.c., quanto dalle sanzioni processuali propriamente dette. Essa rientra, secondo l’impostazione ormai consolidata, nella categoria delle sanzioni civili indirette, ossia misure afflittive patrimoniali che, pur non incidendo direttamente sull’interesse pubblico, mirano a tutelare la parte lesa da un uso distorto dello strumento processuale. Il giudice di Pisa, muovendo da tale qualificazione, ha chiarito che la condanna per lite temeraria postula un quid pluris rispetto alla semplice soccombenza, richiedendo un comportamento antigiuridico che tradisca i principi di lealtà e correttezza processuale sanciti dagli artt. 88 e 92 c.p.c.
La decisione pisana si inserisce in continuità con gli orientamenti espressi dalla Corte di cassazione, che negli ultimi anni hanno progressivamente definito il perimetro applicativo dell’art. 96 c.p.c. e il suo rapporto con il processo tributario. La pronuncia n. 4702/2025, in particolare, affronta la questione nell’ambito di una controversia sull’imposta di registro, riconoscendo la legittimità della condanna per lite temeraria disposta dalla Commissione tributaria regionale nei confronti dell’amministrazione finanziaria. La Suprema Corte ha precisato che la responsabilità aggravata, di cui al terzo comma dell’art. 96, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma implica pur sempre, sotto il profilo soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente. Tali elementi si manifestano nella consapevolezza dell’infondatezza delle proprie tesi o nella mancanza della diligenza minima necessaria per avvedersi della loro evidente inconsistenza.
L’intervento della Cassazione ha così confermato la lettura secondo cui la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere disposta anche d’ufficio, in quanto misura afflittiva volta a sanzionare l’abuso del processo in sé, indipendentemente dalla prova del danno arrecato alla controparte. Tale approccio, già delineato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9912/2018, è stato ripreso e precisato nel caso del 2025, in cui la Corte ha valorizzato la condotta pretestuosa dell’Ufficio, che aveva reiterato censure già dichiarate infondate in giurisprudenza consolidata. In questa prospettiva, la temerarietà non si identifica con la semplice infondatezza della pretesa, ma si concreta nell’uso distorto dello strumento processuale, volto a protrarre indebitamente il giudizio o a contestare principi ormai stabiliti.
La successiva ordinanza n. 13315/2025, anch’essa della Sezione tributaria, rafforza il medesimo indirizzo. In quel caso, la Corte ha ritenuto legittima la condanna per lite temeraria irrogata nei confronti dell’amministrazione per la pervicace reiterazione di argomentazioni identiche a quelle già rigettate in numerosi giudizi analoghi. La Suprema Corte ha così ribadito che l’accertamento della mala fede o della colpa grave costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità, purché sorretto da motivazione congrua e coerente. Tale orientamento rafforza il principio per cui la valutazione della temerarietà della lite è strettamente connessa al comportamento processuale complessivo della parte e alla sua conformità ai doveri di correttezza e diligenza.
Il collegamento tra le due ordinanze della Cassazione e la sentenza pisana risulta di particolare interesse sistematico. Quest’ultima, pur giungendo a escludere la condanna per lite temeraria, applica coerentemente i principi delineati dalla giurisprudenza di legittimità, richiamandone espressamente i precedenti e riconoscendo la natura composita dell’art. 96 c.p.c., articolato in tre livelli di responsabilità: quella per dolo o colpa grave (comma 1), quella per mancanza di normale prudenza (comma 2) e quella sanzionatoria di ufficio (comma 3). In tal senso, la Corte di Pisa dimostra come il giudice tributario sia oggi pienamente inserito nella logica del diritto processuale civile, potendo applicare in via diretta gli strumenti di tutela volti a reprimere l’abuso del processo, pur nel rispetto delle peculiarità del rito tributario.
L’articolata motivazione pisana offre inoltre un utile spunto per riflettere sul rapporto tra autotutela amministrativa e responsabilità processuale. L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, infatti, determina la cessazione della materia del contendere ma non estingue automaticamente le questioni accessorie, quali le spese e l’eventuale risarcimento ex art. 96 c.p.c. La Corte sottolinea che la cessazione del contendere non esclude la possibilità di valutare la condotta processuale della parte resistente, la quale, sebbene abbia rimosso l’atto illegittimo, può aver arrecato un danno ingiusto per comportamento negligente o intempestivo. Tuttavia, nel caso concreto, l’annullamento tempestivo e motivato dell’avviso di accertamento, disposto prima della scadenza del termine di decadenza, ha escluso la configurabilità della mala fede o della colpa grave, trattandosi di un esercizio legittimo del potere di autotutela.
La prospettiva che emerge è quella di una funzione equitativa e correttiva del giudizio tributario, orientata a garantire un equilibrio tra l’effettività della tutela del contribuente e la legittima difesa dell’interesse erariale. L’istituto della responsabilità aggravata, in questa chiave, assume un ruolo di garanzia sistemica, volto a sanzionare comportamenti processuali distorti senza comprimere il diritto di azione dell’amministrazione. Si tratta di un approccio che riflette l’evoluzione del diritto processuale tributario verso una piena assimilazione ai principi del giusto processo, come delineato dall’art. 111 della Costituzione e dalle riforme più recenti, in particolare la c.d. Riforma Cartabia, che ha introdotto il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. prevedendo una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende per l’abuso del processo.
L’analisi congiunta delle tre pronunce e del quadro normativo consente di formulare alcune considerazioni conclusive di ordine sistematico. Anzitutto, la giurisprudenza di merito e di legittimità converge nell’affermare che la condanna per lite temeraria costituisce misura eccezionale e di stretta interpretazione, in quanto incide su un diritto costituzionalmente garantito quale l’accesso alla giustizia. Ne consegue che la mala fede o la colpa grave non possono essere desunte dalla semplice infondatezza della pretesa, ma devono risultare da un complessivo atteggiamento di abuso o di negligenza grave. In secondo luogo, la funzione sanzionatoria dell’art. 96 c.p.c. deve essere letta in connessione con i principi di proporzionalità e di ragionevole durata del processo, al fine di evitare che il rimedio divenga esso stesso strumento di dissuasione eccessiva o di compressione del contraddittorio.
La sentenza della Corte di Pisa rappresenta un momento di consolidamento di un orientamento che, pur improntato a rigore, tende a valorizzare la funzione di equilibrio del giudizio tributario tra efficienza, lealtà e tutela dei diritti. Il dialogo tra giudici di merito e Corte di cassazione ha contribuito a delineare un modello di responsabilità processuale coerente con i principi costituzionali e con la necessità di preservare l’integrità della funzione giurisdizionale. Ne emerge una visione unitaria della lite temeraria come fattispecie di abuso del processo, la cui repressione, pur doverosa, deve essere esercitata con prudenza e secondo criteri di effettiva colpevolezza soggettiva.
24 ottobre 2025
Lo stesso elaborato anche su taxlegaljob.net
