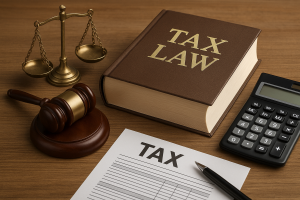A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
La recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, n. 30780 del 15 settembre 2025, costituisce un rilevante punto di approdo in ordine all’estensione applicativa dell’art. 572 cod. pen., il quale disciplina il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi. In particolare, la decisione affronta con rigore ermeneutico il tema della riconducibilità a tale fattispecie incriminatrice di comportamenti verbali reiteratamente offensivi, capaci di ledere la dignità e l’equilibrio psichico della vittima, pur in assenza di manifestazioni fisiche di violenza.
Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte trae origine dalla condanna inflitta nei confronti di un genitore accusato di aver rivolto, alla propria figlia minore, espressioni gravemente denigratorie, con particolare riferimento all’aspetto fisico della medesima. Le offese, reiterate nel tempo e contestualizzate in un arco cronologico di circa sei mesi (gennaio-luglio 2020), sono state ritenute di tale intensità da configurare un contesto esistenziale costantemente umiliante, con conseguenze afflittive sulla personalità in formazione della minore. La peculiarità della vicenda risiede altresì nella contestualizzazione pandemica, la quale aveva imposto una convivenza fisicamente limitata tra i soggetti coinvolti, ma non aveva interrotto il rapporto comunicativo, sebbene deformato in senso patologico dalla condotta paterna.
La Corte, valorizzando la specificità della relazione genitore-figlio, ha affermato che il requisito dell’abitualità, elemento strutturale della fattispecie criminosa in esame, può ritenersi sussistente anche laddove la frequenza materiale degli incontri sia ridotta, purché emerga una persistente modalità relazionale improntata alla sopraffazione, alla denigrazione e alla disistima sistematica. In tal senso, la Corte ha confermato la correttezza dell’operato dei giudici di merito che avevano ancorato l’accertamento della responsabilità penale ad una molteplicità di elementi convergenti, in grado di dimostrare la reiterazione delle offese e l’effettivo impatto lesivo sulla vittima.
La sentenza in esame si distingue altresì per un’affermazione di principio di particolare rilievo: il disvalore penale delle parole, quando queste si connotino per il loro contenuto fortemente umiliante, gratuito e reiterato, risulta pienamente equiparabile a quello delle condotte fisicamente violente. La violenza verbale, in contesto familiare, assume infatti una valenza lesiva aggravata dalla prossimità affettiva che dovrebbe costituire presidio di protezione e cura, trasformandosi invece in veicolo di annichilimento della persona offesa. La vittima, peraltro minore d’età e dunque dotata di una peculiare vulnerabilità psicoemotiva, è risultata oggetto di un’aggressione all’identità personale che ha inciso profondamente sul suo sviluppo psicologico, determinando una condizione di sofferenza costante.
In merito alla valutazione probatoria, è d’uopo evidenziare come la Corte abbia dato rilievo alla solidità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, giudicate coerenti, precise e dettagliate, nonché riscontrate da fonti esterne, quali le testimonianze dei familiari e la documentazione predisposta dai servizi sociali. Degna di nota risulta la metodologia processuale adottata in sede di appello, ove si è proceduto alla diretta visione della videoregistrazione dell’audizione protetta della minore, strumento ritenuto idoneo ad assicurare una più accurata percezione della credibilità soggettiva e dell’attendibilità oggettiva delle dichiarazioni rese.
Sotto il profilo processuale, è stato escluso qualsivoglia vizio motivazionale, così come è stata rigettata la doglianza difensiva circa la presunta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. In particolare, la Corte ha chiarito che il richiamo ad un episodio successivo ai fatti oggetto di imputazione – ovvero un messaggio inviato dal padre alla figlia – non è stato utilizzato quale fondamento della responsabilità, bensì quale elemento sintomatico della permanenza dell’atteggiamento svilente, utile a rafforzare la ricostruzione del quadro relazionale disfunzionale.
La decisione si colloca dunque nel solco di un orientamento giurisprudenziale che, pur risalente, trova nella presente pronuncia un’importante conferma e ulteriore evoluzione. La tipicità del reato di maltrattamenti è oggi letta attraverso una lente interpretativa che privilegia la tutela sostanziale della persona, ancor più quando trattasi di soggetto minorenne, ponendo l’accento sulla qualità afflittiva della relazione familiare, più che sulla mera materialità della condotta.
Appare evidente come la pronuncia in esame consolidi un approccio interpretativo volto a riconoscere e sanzionare le forme più insidiose di violenza intrafamiliare, che si manifestano attraverso parole, atteggiamenti e silenzi eloquenti, capaci di produrre effetti lesivi profondi e duraturi. Essa assume una valenza paradigmatica nell’evoluzione della tutela penale dei soggetti deboli, confermando il ruolo centrale del giudice nel ricostruire con attenzione e sensibilità il contesto relazionale, attribuendo valore giuridico alla sofferenza psichica derivante da forme di maltrattamento che, seppur prive di contatto fisico, risultano egualmente distruttive dell’integrità personale della vittima.
1 ottobre 2025