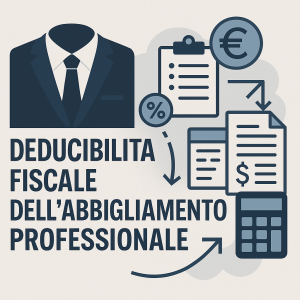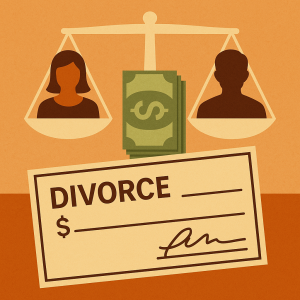
A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola
La disciplina dell’assegno divorzile ha attraversato, negli ultimi anni, un’evoluzione concettuale di significativa rilevanza sistematica, che ha profondamente inciso sulla sua funzione giuridica e sul suo inquadramento teorico all’interno dell’ordinamento italiano. Tale trasformazione si è concretizzata nel definitivo superamento del criterio del tenore di vita endoconiugale quale parametro unico ed esclusivo per la determinazione dell’assegno, a favore di un modello valutativo complesso e costituzionalmente orientato. Il momento di svolta è stato segnato dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287 dell’11 luglio 2018, la quale ha segnato l’abbandono di un impianto assistenzialistico meramente riparatorio, introducendo una lettura multifunzionale dell’istituto, in linea con i principi di solidarietà e pari dignità sanciti dagli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione.
La recente sentenza del Tribunale di Crotone del 17 luglio 2025 si colloca in modo emblematico nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, costituendo un esempio virtuoso di recepimento e applicazione dei canoni ermeneutici delineati dalle Sezioni Unite. Il giudice calabrese ha adottato un approccio argomentativo sofisticato, fondato su un’analisi integrata e comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ponendo in rilievo il contributo non meramente patrimoniale fornito dal coniuge istante nella costruzione del progetto familiare. In tal senso, si afferma un criterio composito, che postula la necessità di una valutazione globale delle circostanze fattuali, con particolare attenzione alla durata del matrimonio, all’età dell’avente diritto, alle scelte condivise nella vita coniugale e agli eventuali sacrifici professionali sostenuti.
L’assegno divorzile assume così una triplice funzione: assistenziale, compensativa e perequativa. La prima, in senso stretto, è finalizzata a garantire un sostegno al coniuge privo di mezzi adeguati e incapace, per ragioni oggettive, di procurarseli autonomamente. La seconda ha lo scopo di riconoscere il contributo apportato alla formazione del patrimonio comune e alla conduzione della vita familiare, valorizzando le rinunce e i sacrifici compiuti in funzione della coesione coniugale. La terza funzione, infine, mira a riequilibrare le disparità economiche scaturite dalla cessazione del vincolo matrimoniale, attraverso una redistribuzione equa e giustificata dalle dinamiche pregresse del rapporto coniugale.
Tale nuova impostazione comporta, sul piano applicativo, una profonda revisione della prassi giudiziaria. Non è più sufficiente accertare l’autosufficienza economica dell’ex coniuge richiedente secondo parametri astratti e statici; è invece necessario svolgere un’indagine approfondita sulle concrete prospettive reddituali, sulle potenzialità lavorative residuali, nonché sul pregresso apporto al ménage familiare. L’autosufficienza economica, intesa come capacità di generare reddito sufficiente a garantire una vita dignitosa, non può prescindere dalla considerazione delle aspettative professionali sacrificate e dal ruolo svolto all’interno della famiglia, anche ove privo di diretta rilevanza economica.
La funzione compensativa dell’assegno divorzile, pertanto, assume un rilievo centrale nella ricostruzione sistematica dell’istituto. Essa implica un riconoscimento giuridico del lavoro non retribuito svolto in ambito domestico e familiare, che ha consentito all’altro coniuge di realizzare una carriera professionale più proficua. Questo approccio consente di superare la tradizionale dicotomia tra lavoro produttivo e lavoro riproduttivo, conferendo dignità giuridica alle attività di cura e alla gestione della quotidianità familiare, spesso sottovalutate in sede di determinazione dell’assegno.
La sentenza del Tribunale di Crotone si distingue, altresì, per l’adozione di una metodologia valutativa improntata a equità sostanziale, in cui il giudice si è fatto interprete di una visione costituzionalmente conforme della crisi familiare. La decisione non si è limitata a quantificare l’assegno sulla base di parametri quantitativi, ma ha svolto un’attenta analisi qualitativa delle dinamiche relazionali pregresse e delle implicazioni economiche ad esse connesse. Si tratta di un’applicazione esemplare del principio di personalizzazione della tutela, che consente di cogliere la specificità del singolo rapporto coniugale e di offrire una risposta giuridica adeguata alle peculiarità del caso concreto.
L’approccio adottato dal Tribunale di Crotone rappresenta un’applicazione avanzata del nuovo paradigma ermeneutico dell’assegno divorzile, orientato a garantire un’effettiva e sostanziale uguaglianza tra gli ex coniugi anche nella fase patologica della relazione. Si configura così una lettura moderna e costituzionalmente orientata dell’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, in cui l’assegno divorzile assume la funzione di strumento di giustizia redistributiva, capace di colmare le diseguaglianze generate all’interno del vincolo matrimoniale e di valorizzare gli apporti non patrimoniali che ne hanno contraddistinto la durata. La decisione in esame si pone, dunque, come tappa significativa nel processo evolutivo della giurisprudenza di merito in materia, offrendo un contributo rilevante all’elaborazione teorica e applicativa della disciplina dell’assegno divorzile nel contesto contemporaneo.
29 agosto 2025